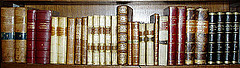40. Della coltivazione de’ monti dell’abate Bartolomeo Lorenzi: “Dell’educazione dei contadini”.
…a cura di Aldo Ridolfi
Per le tue domande scrivi a: aldo.ridolfi@libero.it
5: Dell’educazione dei contadini
Già nelle precedenti stagioni Lorenzi aveva sempre considerato anche la figura del contadino, del colono nella trama dell’economia collinare, ora stimolandone l’impegno, ora riprendendolo per comportamenti non conformi. Non fa eccezione nell’”Autunno”.
Il colono non diventa mai, nell’equilibrio complessivo del poema, il protagonista assoluto. Questo privilegio Lorenzi non glielo concede, ma di sicuro lo ritiene figura in grado di realizzare, in simbiosi con la terra, un ideale di vita laboriosa, onesta e produttiva di beni.
Prendiamo l’ottava XIX dove è ancora la vigna ad essere protagonista (con la semina, infatti, occupa uno spazio significativo delle 146 ottave). Spesso è l’uomo a costituire la “causa efficiente” del successo agrario. Scrive infatti l’abate:
Se il zappator sollecito non manca
dar la vedrai di nuova vita indizio
La ricostruzione sintattica dei due versi può essere la seguente: «quando non manca il sollecito zappator, vedrai (la vite) dare indizio di nuova vita, cioè la vedrai rifiorire». Ancora una volta Lorenzi riconduce il successo agrario nelle mani del lavoratore, nella sua buona volontà, nella sua laboriosa perizia (che il poema mira a migliorare sempre più). Infatti, nella vigna, la terra andava smossa, le erbacce sradicate così da predisporre il terreno ad accogliere la pioggia. Ancora negli anni Settanta c’era chi raccontava di file di coloni con la zappa sulla spalla che si recavano, in prossimità di precipitazioni, intraviste grazie ad esperienza secolare, nelle vigne a rimuovere la terra.
Il contadino di Lorenzi è colto anche in altre sue manifestazioni. All’ottava CXXI annota:
Canta il bifolco
Il canto, soprattutto femminile, durante lo svolgimento dei lavori campestri o casalinghi, era una costante, rimasta fino all’arrivo dei… “transistor” la cui magia aveva messo in pensione le ugole contadinesche.
Vale la pena di riportare per esteso l’ottava CXXI perché racconta del rapporto uomo – animale con un po’ di poesia, certo, ma indice anche di profondo rispetto:
Canta il bifolco intanto, e il bue che ascolta
qualche dolcezza al core andar si sente.
S’arresta al noto fischio e se talvolta
ne sgridi il passo, del suo error si pente.
S’affretta al fin del solco, ove si volta
l’aratro, e ‘l suo riposo gli consente:
indi, senza aspettar s’altri lo istiga,
docil ritorna a la seconda riga.
La si legga e la si rilegga questa ottava: è di una straordinaria delicatezza e ci consegna un rispetto reciproco bue – uomo che si esprime in quel non inverosimile pentimento del bue e in quel lasciar riposare l’animale alla fine del solco, prima di voltare e compierne un altro. Del resto noi tutti s’imparava a memoria quel pascoliano “T’amo, o pio bove” e lo si recitava in classe con quel tono cantilenante che ancora ricordo e che la maestra non riusciva a farci mutare.
Quando il contadino s’impegna nel suo compito produce risultati strepitosi e può essere additato dal poeta a mo’ d’esempio:
Impara da colui che brevi zolle
del proprio campicel tratta col rastro. (stanza XXI)
La valutazione dell’opera del contadino, dunque, è positiva: l’abate gli riconosce il ruolo di modello da imitare, di “maestro”.
(Aldo Ridolfi, 5 continua)