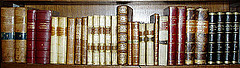Preite Carmelo
…a cura di Giancarlo Volpato
Per le tue domande scrivi a: giancarlovolpato@libero.it

Musicista, compositore musicale, direttore di banda e d’orchestra, Carmelo Preite nacque a Presicce, in provincia di Lecce, il 14 febbraio 1866. Già da bambino, durante le scuole elementari, manifestò una grande propensione per la musica: all’età di otto anni, dopo l’esecuzione di un “pezzo variato” per tromba (uno strumento che aveva imparato da piccolo), in un paese vicino a Santa Maria di Leuca, conobbe già gli applausi della folla: grazie anche alla bravura e all’abilità con la quale suonava questo strumento, a dodici anni fu ammesso immediatamente al famoso Conservatorio musicale di San Pietro a Maiella di Napoli, in maniera gratuita. Ebbe come maestri Paolo Serrao e Giuseppe Martucci, entrambi compositori importanti e pianisti di fama; gli furono compagni di studio Mario Pasquale Costa, Umberto Giordano e Francesco Cilea: maestri e compositori assai celebri e di fama internazionale che lo ebbero sempre come amico, che l’avevano applaudito e che non lo dimenticheranno mai; fu con loro quando nacque il gruppo dei wagneriani, ossia degli studiosi che subito simpatizzarono con la musica di Richard Wagner; sarà presente quando il sommo compositore verrà in Italia, a Milano, ospite di Giordano. Oltreché suonare la tromba, Preite studiò composizione e strumentazione di banda: fu quest’ultima l’amore più grande della sua vita d’artista.
Infatti, nel 1884 (aveva appena terminato gli studi al Conservatorio e superava di poco i 18 anni), vinse il concorso nazionale quale maestro di banda militare nel 45° Reggimento di Fanteria a Bergamo: sarà questo il primo dei molti viaggi attraverso l’Italia. Infatti, due anni dopo, venne traferito a Messina con il Reggimento medesimo; aveva già cominciato a comporre musica per banda oltreché a modificare alcuni pezzi, scritti per orchestra, adeguandoli agli strumenti: sarà qui, nella città dello Stretto, che il giovane Carmelo Preite acquisterà una fama che lo porterà ad essere applaudito quale direttore: disponibile, attento, preciso e inventivo. Una sera della fine febbraio 1887, al teatro “Vittorio Emanuele” di Messina accadde un fatto che lanciò il giovane: la malattia improvvisa del maestro-direttore dell’orchestra avrebbe messo a disagio impresario, cantanti, orchestrali e il pubblico se il Nostro non fosse stato chiamato al posto di Alessandro Pomé, noto e applaudito. Preite diresse il Mefistofele di Arrigo Boito in modo tale che gli applausi furono assai numerosi e la “Gazzetta di Messina” del giorno successivo ne parlò in modo sovrano; la bravura del giovane attirò l’attenzione e per lui la strada della direzione d’orchestra non si chiuderà mai. Il giornale sottolineava che, pure avendo accettato solo al mattino, “quel giovane, piccolo, nervoso, con due baffi arricciati e i sopraccigli folti diresse il poderoso melodramma boitiano con un impeto e una sicurezza da sbalordire tutti”. Sarà egli stesso, a volte, a scegliere quale delle due possibili direzioni, preferendo sempre – se contemporanee – quella bandistica
Nella città siciliana compose ed eseguì una marcia, Sveglia sul campo, delicata ma vigorosa nel suono, che diresse con la banda; si esercitò pure nella prima sinfonia da lui composta: Ricordi del faro. L’estro del musicista aveva trovato la strada.
Nel 1889 ritornò nel Nord Italia: prima, di stanza a Peschiera del Garda e, poi, a Verona; vi rimarrà, senza spostamenti, per oltre un decennio e la città atesina, il lago e tutto il territorio scaligero saranno la nuova vita; oltreché prendere la cittadinanza, incontrerà, a Bardolino, Amelia Gelmetti che sposerà e sarà la gioia della sua vita. Carmelo Preite dirigerà opere al Teatro Filarmonico, al Ristori e al Teatro Nuovo. Furono anni importanti nella vita del Nostro e la città stessa conobbe la grande vitalità del giovane; nel settembre 1889, infatti, la monumentale Piazza Bra conobbe il suo primo concerto pubblico: da ottimo conoscitore della musica, Preite seppe “convertire” in concerti per banda le musiche di Arrigo Boito, Charles Gounod, Gioacchino Rossini, Giacomo Meyerbeer alle quali aggiunse due sue composizioni proprio per quel pubblico veronese che era diventato il suo: una marcia, Esposizione, e una polka, dal titolo prettamente dialettale locale: Oh, che putele! Fu un evento, quella sera: il quotidiano “L’Arena”, del giorno dopo, ne descrisse il coinvolgimento del pubblico; nella sua lunga e brillante carriera, Preite adotterà, da allora in poi, quei criteri di finezza ed eleganza dei quali tutte le bande musicali da lui dirette potranno godere. Questo suo primo anno veronese fu molto stimolante: tra le molte cose, diresse la banda cittadina che suonò all’interno dell’Arena.
L’anno successivo, il 45° Reggimento di Fanteria fu trasferito al campo di Castiglione delle Stiviere dove compose un’operetta, La spedizione dei coscritti in Africa su libretto di un componente della sua banda. Ritornò a Verona e Carmelo Preite – al di là degli impegni – abbracciò la cultura e la bellezza della società veronese di allora. Gli anni Ottanta del diciannovesimo secolo rappresentarono uno dei più importanti momenti per una società che, nonostante il dramma dell’inondazione dell’Adige del 1882, seppe vivere in maniera gioconda, frequentando teatri, gare sportive, cortei, veglioni, feste come quelle del carnevale ed altre. Con l’ardore meridionale, Preite aveva trovato a Verona quanto cercava. Cominciò a conoscere il dialetto locale, i canti corali, il folclore e la musa vernacola: ispirandosi a queste ultime forme della tradizione locale compose Musi da du musi, maschera carnevalesca con una metafora molto chiara, I pelaochi e El Monte Baldo: l’uomo della Puglia si era immerso nella bellezza di una città la cui ricchezza folklorica e tradizionale aveva seminato e seminerà ancora per tanto tempo. Nel 1892 accadde il centenario di “Savoia Cavalleria”: la stampa nazionale s’appropriò del torneo che il reggimento, dal nome della casa reale – presente per l’occasione – ingaggiò nell’Arena: e Carmelo Preite compose una Marcia trionfale, in stile mendelssohniano: la suonarono la sua banda e quella dei Savoia, arricchendo la bellezza della giornata e del monumento romano con la Cavalcata delle Walkirie di R. Wagner e con la sesta Rapsodia ungherese di Franz Liszt.
La Verona dell’epoca era ricca e piena di una lietissima brigata di scapigliati ingegni: di essa il Preite fu uno degli instancabili animatori; ma lo sarà, condividendo felicemente il motto “veronesi tuti mati” soprattutto alla fine del secolo, nei primi anni del successivo, abbracciando maggiormente con il cuore gli anni Venti del Novecento assieme a Filippo Nereo Vignola, Sandro Baganzani (v. questo Sito), Angelo Dall’Oca Bianca, Sirio Caperle, Vittorio e Gianfranco Betteloni, Renato Simoni, Giuseppe Adami, Lina Arianna Jenna (v. questo Sito), Maria Labia (v. questo sito). Tra le altre cose e le direzioni di banda e orchestra, egli compose due serenate: Veneziana e Fra vita e morte, eseguite nel luglio 1892 dalla società mandolinistica “Margherita”, in un concerto benefico; fu attratto dai bambini per i quali compose una canzone dal titolo Il perdono della mamma. Nel 1893 ridusse, per banda, I pagliacci di Leoncavallo e i giornali dell’epoca applaudirono al successo “per avere dato alla parte melodica l’espressione della voce, la seduzione del canto, con predominio degli strumenti ad arco”.
Nel 1894 si riaprì il vecchio Teatro “Ristori” e la stagione lirica con la Gioconda, La Traviata e un’opera del veronese Ferruccio Cusinati, Medora: ebbero tutte la direzione di Carmelo Preite; fu così applaudita la stagione che l’impresario ne aggiunse una quarta, la Manon Lescaut che decretò, per il maestro salentino, una serata d’onore.
Questa vittoriosa affermazione in veste di direttore d’orchestra, per il nostro musicista ebbe notevoli ripercussioni per la sua carriera. Alberto Franchetti, nel 1895, gli affidò la direzione e la concertazione della sua opera, Fior d’Alpe, su un idillico libretto di Leo di Castelnuovo (pseudonimo di Leopoldo Pullé), alla prima tenuta alla Scala di Milano e poi ritornata a Verona nei teatri cittadini. La stagione di quell’anno – completata da alcune recite de I pagliacci – era stata organizzata per la festosa inaugurazione dei muraglioni dell’Adige: al Ristori, proprio per rendere omaggio al fiume che fu la vita della Verona dei secoli, accanto ad altre musiche, venne eseguita una serenata composta da Preite su versi di Berto Barbarani (v. questo Sito) in ottave a rima alternata, Su l’Àdese: proprio in quel tempo era uscito il primo canzoniere del poeta, El rosario del cor, su cui l’Adige brillava.
La fama del Nostro aprì le porte del Teatro “Vittorio Emanuele” di Torino dove fu chiamato a dirigere due novità: La tentazione di Gesù, musica di Carlo Cordara su testo di Arturo Graf e Maricca di Marco Falgheri: l’ottima direzione concertistica di Preite non fu sufficiente a fare ricordare al futuro due opere praticamente dimenticate come scrissero i giornali dell’epoca. L’intensa attività delle stagioni liriche tra 1895 e 1897 lo videro sempre sui palcoscenici veronesi e su tutte fu ricordato, dai giornali, un mirabile Mefistofele. La grande stagione scaligera stava per chiudersi: nel marzo 1897 diresse un’elogiata edizione della pucciniana Bohème ed un’opera nuova, Lena: dramma lirico in due atti, di Torquato Zignoni.
Il 45° Reggimento fu trasferito, nella primavera di quell’anno, a Vercelli. Ormai, però, la fama di Carmelo Preite, grande direttore di quella banda, aveva conquistato anche e soprattutto i teatri; pure nella città piemontese s’aprirono subito i cancelli e Giacomo Puccini, personalmente, gli chiese di dirigere la Bohème e la Manon Lescaut. L’editore Ricordi, su consiglio di G. Verdi, fece dirigere La risurrezione di Lazzaro, un oratorio del giovane prete Lorenzo Perosi: le repliche furono molte dopo il successo nella cattedrale di Vercelli; l’anno successivo, 1898, a “La Fenice” di Venezia fu proprio il presbitero a pregarlo di dirigere la prima de La Risurrezione di Cristo e così avvenne pure a Vicenza e al “Comunale” di Bologna.
Le fatiche del direttore non affievolirono l’estro del compositore per l’ambiente veronese: artistico e poetico. Diventarono repertorio per complessi vocali A la luna, su versi di Barbarani, un inno A Bardolino, a quattro voci, su parole di Vittorio Betteloni, A Euterpe, inno sociale della corale di Nogara dedicata alla dea della musica, un coro Madonna Verona, Cinque villotte veronesi su motivi delle vendemmiatrici del vino di Bardolino, Rose de Rovigo e altre cantate. Più tardi, quando ritornerà a Verona, dedicherà il coro El papà del gnoco, mentre nel 1931, cantato da un coro di 600 voci areniane, comporrà Inno a Verona sempre del Barbarani.
Lasciata Vercelli, la banda del Reggimento Fanteria andò a Lecce dove Preite diresse grandi opere e tra queste, nel 1901, anche la Bohème; il bambino che cantava aveva già una voce molto bella e al direttore piacque molto: era Tito Schipa che ricordò sempre con devozione profonda chi l’aveva lanciato. Il Nostro era diventato talmente celebre che, d’ora in poi, la sua vita sarà quella del direttore-girovago; a Torino, lanciò Mazeppa di Adamo Minhejmer, polacco; poi ancora a Lecce, quindi a Napoli finché, nel 1906, avvenne un fatto che segnò il resto della sua vita. Carmelo Preite risultò vincitore, tra cinquantatre aspiranti, quale direttore della Banda Cittadina di Venezia. Si trasferì in laguna e fu – lo disse sempre – il periodo più bello e felice. Pubblicò il manuale Istrumentazione per banda passato alla storia per la straordinaria polifonia descritta e, poi, applicata dai suonatori. Piazza San Marco diventò il fulcro dei concerti dal 1907 e Preite dedicò alla musica mondiale (da Puccini a Zandonai, da Mascagni a Strauss, da Wolf-Ferrari a Strawinsky, da Verdi a Beethoven e via discorrendo) programmi che richiamarono gli stessi autori oltreché pubblico applaudente. Il Teatro “La Fenice” si contese il salentino il quale chiese a Pietro Mascagni di potere ridurre Isabeau per banda: da un tavolo del Caffè Florian questi applaudì Preite, in pubblico, per la bellezza dell’opera dell’artigiana professionale e gentile.
Il Nostro iniziò ad insegnare al Liceo Musicale “Benedetto Marcello” di Venezia; non dimenticava la direzione delle opere a “La Fenice”; andò a Parigi a dirigere I gioielli della Madonna di Wolf-Ferrari. Richiamato in servizio militare, quale ufficiale, all’inizio della prima guerra mondiale, fu raggiunto dal figlio Mario, sottotenente di fanteria, da poco uscito dall’Accademia Militare di Modena: appena ventenne, questi cadde alla testa del suo plotone sul Carso. Finito il conflitto, Carmelo Preite, alla memoria del figlio caduto da eroe e insignito di medaglia d’argento, dedicò iniziative benefiche, serate a favore dei soldati e al culto della memoria dei combattenti mai più ritornati; furono con lui i più celebri cantanti di allora: da Tito Schipa a Beniamino Gigli, da Aureliano Pertile a Juanita Caracciolo; musicò favole e libretti per bambini quali Biancabella e Fiordilino. Ritornò a dirigere la banda, salì sui palchi di Verona, Mantova, La Spezia, Monaco di Baviera; portò al successo I misteri gaudiosi di Nino Cattozzo. Nel 1927 la sua banda fu chiamata a Francoforte sul Meno: i concerti conobbero l’apoteosi tanto che il ritorno a Venezia segnò, per Carmelo Preite, un inno alla sua grandezza, alle sue opere, ai suoi suonatori. Piazza San Marco lo vide, ufficialmente, per l’ultima volta: chiese il collocamento a riposo e si congedò. Lo salutarono perfino i gerarchi, allora potenti e importanti, ai quali – però e con il massimo riguardo – egli non aveva mai concesso nulla: la gloria di un italiano recava “grandezza” all’Italia intera, gli scrisse uno di questi, veneziano. I fondachi lagunari, dove egli faceva suonare la banda, lo ricordarono per l’eleganza, la capacità assoluta d’inserire gli strumenti in luoghi dove gli abitanti non avevano mai ascoltato.
Dieci anni dopo, nel 1937, piazza San Marco lo richiamò per dirigere opere immortali, da lui riscritte per la banda: dal Bolero di Ravel, ad alcune parti del Tristano e Isotta di Wagner, a Paisiello, Vivaldi, Rossini, Giordano, Wolf-Ferrari, Casella, Verdi.
Carmelo Preite aveva la sua casa a Bardolino, ma la prematura scomparsa della moglie, nel 1940, lo portò a Milano con le figlie entrambe laureate; non dimenticò la Puglia, andava a Gioia del Colle a dirigere, come accettava ancora di calcare i palcoscenici di Bologna, Venezia, Milano; prediligeva gli incontri con i mai perduti amici veronesi. Non amò mai la solitudine e tanto meno le giornate senza fare nulla: riorganizzò complessi bandistici, girò l’Italia grazie al mai sopito amore per coloro ch’egli aveva prediletto. Fu modesto, silenzioso, nonostante i giornali parlassero molto di lui; lasciò un testamento molto scabro dove sottolineò di “fare silenzio”, senza cortei, di fare celebrare delle messe, poiché egli fu, sempre, un uomo pieno di fede cristiana. Scrisse di essere sepolto a Bardolino accanto alla “dolcissima mia Amelia”. Così accadde, infatti, all’indomani della sua scomparsa avvenuta a Milano il 27 marzo 1952 dov’era con le sue figlie. I giornali, le riviste musicali lo ricordarono. A lui furono dedicate delle vie a Presicce-Acquarica, Gioia del Colle, Casarano (Bari), Milano, Venezia, Garda e il lungolago a Bardolino; il 26-27 marzo 2023 Bardolino celebrò, per lui, una giornata di festa.
Bibliografia: Franco Abbiati, Dio ha ricevuto l’anima di Carmelo, “Corriere d’informazione”, 11-12 aprile 1952, pp. 2-3; Giuseppe Silvestri, Carmelo Preite: ritratto di un musicista, Verona, Vita Veronese, 1953; Elisa Grossato, Preite Carmelo, in Dizionario Biografico dei Veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona 2006, pp. 671-672; Francesco Giannini, Preite Carmelo, https.//www..ilsaxofonoitaliano.it/artisti/preite-carmelo/, 2008; Roberto Orlando, Carmelo Preite, una delle più prestigiose “bacchette” d’orchestra tra ’800 e ’900, “Nuova Taurisano” (Lecce), 2009, pp. 8-9; Gaspare Nello Vetro, Le bande musicali del Regio Esercito, Roma, Ufficio storico SME, 2010, pp. 123-127; Fabrizio Carcagni, Carmelo Preite un altro grande maestro del passato, “Voci di Banda” (Monteroni di Lecce), 26 ott. 2022, pp. 1-8.
Giancarlo Volpato
FONTI:
Foto da: Autore: Picasa | Ringraziamenti: ANSA – Copyright: ANSA
Foto da: https://www.ilsaxofonoitaliano.it/artisti/preite-carmelo/